L’ira Dei Vilipesi
Guido Pagliarino
26 settembre 1943, Napoli è sul punto di ribellarsi ai tedeschi occupanti. Rosa, prostituta e borsanerista già confidente della polizia politica fascista, muore per cause violente. Gennaro, suo presunto assassino, è fermato e interrogato inutilmente da un ancor inesperto vice commissario, Vittorio. Poco dopo s'accende l’insurrezione che passerà alla storia come Le Quattro Giornate di Napoli. Vi aderiscono il vice commissario e, stranamente liberato dal questore in persona, il presunto assassino di Rosa. Partecipa alla lotta anche la giovane Mariapia che, dopo aver subito uno stupro plurimo da parte tedesca, brama vendetta. Presto Gennaro risulta essere suo parente. Avviene un altro assassinio, bersaglio un tabaccaio, anch'egli imparentato con Mariapia.
Affresco storico sociale con aspetti polizieschi ambientato a Napoli prevalentemente nel 1943, durante le storiche Quattro Giornate in cui la città si liberò da sola dell’occupante nazista. Accanto ai personaggi in carne e ossa è protagonista il furore, sia l’ira collettiva che erompe sul campo di battaglia e ha per corollario, da parte vincitrice,stupri e altre bestialità, sia, parallelamente, la collera che s’esprime nella ribellione a privati soprusi impuniti dall’autorità e ormai insopportabili. Se un popolo oppresso può di pieno diritto ribellarsi e insorgere e se, come ammetteva addirittura san Tommaso d’Aquino, è consentito l’omicidio del tiranno quando non ci sia altra via per ritrovare la libertà che Dio stesso ha concesso all’essere umano, è lecito o no uccidere un malavitoso che la giustizia non riesce a raggiungere e colpire, il quale continua ad angariare, sfruttare e uccidere il prossimo entro il proprio quartiere? Chi, non avendo altra difesa possibile, ricorra alla difesa estrema è colpevole? E, se sì, fin a che punto? Questo è il dilemma privato che corre lungo il romanzo attraversando la vicenda pubblica della ribellione di Napoli ai tedeschi. La scena si apre sulla morte violenta di Rosa, ricca prostituta e borsanerista già confidente della polizia politica fascista. Gennaro, suo presunto assassino, è fermato e interrogato inutilmente da un ancor inesperto vice commissario, Vittorio D’Aiazzo. Pochissimo dopo, siamo al 26 settembre 1943, s'accende l’insurrezione che passerà alla storia come Le Quattro Giornate di Napoli. Vi aderiscono lo stesso vice commissario e, stranamente liberato dal questore in persona, il presunto assassino di Rosa. Partecipa alla lotta anche la giovane Mariapia che, dopo aver subito uno stupro plurimo da parte tedesca, brama vendetta. Gennaro risulta essere, a un certo punto dell’opera, suo parente. Nel corso degli scontri avviene un altro omicidio che, almeno all’apparenza, come già la morte della prostituta, non è attinente alla rivolta: la vittima è un tabaccaio, cugino di Mariapia, che qualcuno ha sgozzato mentre stava defecando, tagliandogli poi i testicoli. I due decessi sembrano a un certo punto collegarsi, perché i defunti non solo erano entrambi legati alla camorra, ma pure ai servizi segreti militari americani O.S.S. Entrano in scena tra un combattimento e l’altro diversi personaggi tra cui, personaggio secondario ma basilare, l’anziano riparatore di bici Gennarino Appalle che scopre il cadavere del tabaccaio e, al termine d’uno scontro fra insorti e SS tedesche sulla via innanzi alla sua bottega, esce in istrada e, ansante, ne avverte il vice commissario D’Aiazzo, che allo scontro ha partecipato assieme al suo aiutante, l’impetuoso brigadiere Bordin. Il tabaccaio era stato una laida persona, a suo tempo picchiatore della camorra. Relativamente alla morte della prostituta, la soluzione giunge già verso la metà dell’opera. Quanto all’identità dell’assassino del tabaccaio, le indagini di Vittorio D'Aiazzo continuano assai a lungo e l'autore del crimine si svelerà solo nel 1952.
Guido Pagliarino
L’Ira Dei Vilipesi
Romanzo Storico
E-book published by Tektime
Tektime S.r.l.s. - Via Armando Fioretti, 17 - 05030 Montefranco (TR)
Copyright di quest’e-book, © 2018, Guido Pagliarino - All rights reserved
Diritti di traduzione e di pubblicazione in qualsiasi forma dei libri tradotti © Guido Pagliarino - All rights reserved
Diritti di realizzazione di audiolibro in qualsiasi lingua © Guido Pagliarino - All rights reserved
Il copyright, © 2017, del corrispondente Libro cartaceo “L’Ira Dei Vilipesi” appartiene fin a scadenza contrattuale alla Genesi Editrice, via Nuoro 3, 10137 Torino, sito http://www.genesi.org/ (http://www.genesi.org/)
Le immagini di copertina dell’e-book Tektime e del relativo libro cartaceo Genesi Editrice sono realizzate elettronicamente dall'autore © Guido Pagliarino
I personaggi, le vicende, i nomi di persone, enti e ditte e le loro sedi che compaiono nel romanzo, a parte le figure e gli avvenimenti che la Storia ricorda, sono immaginari; eventuali riferimenti alla realtà passata e presente sono casuali e del tutto involontari.
Guido Pagliarino
L’Ira Dei Vilipesi
Romanzo Storico
Capitolo 1
Era stato fermato dagli agenti d’una camionetta di ronda della Pubblica Sicurezza nella tarda serata del 26 settembre 1943, indiziato dell’uccisione d'una certa Rosa Demaggi, bionda ossigenata avvenente, sulla trentina, prostituta benestante e borsanerista al dettaglio: l'uomo, forte accento partenopeo, viso squadrato, corporatura robusta, non grassa, dimostrava una quarantina d’anni, era alto un metro e settantotto, statura sopra la media in quei tempi di diffusa malnutrizione, era calvo nelle aree frontale e temporale e sopra il capo, e attorno alla nuca esibiva una bassa semicorona di capelli bruni tenuti cortissimi con sfumatura alta. Indossava una salopette e una camicia in flanella, entrambe di colore turchino, e calzava leggeri guanti in lana color grigioverde.
Presso la Buon Costume di Napoli era risaputo che Rosa Demaggi si prostituiva nel proprio domicilio, in piazzetta del Nilo, a uomini benestanti. Fino al 25 luglio aveva ceduto i propri favori anche a dirigenti fascisti e, dopo l’armistizio, caduta la città sotto il calcagno germanico, s’era concessa a ufficiali della Wehrmacht e della Gestapo. Per precedenti indagini svolte di concerto, si sapeva nelle sezioni Buoncostume e Illeciti Commerciali, questa creata dopo l’inizio del conflitto per combattere il mercato nero, che la Demaggi, fin dall’estate del '40, aveva chiesto a compenso, preferibilmente, generi alimentari, sigarette e liquori, per farne piccolo traffico a borsa nera; ed era noto ch’ella, ben presto, aveva allargato il giro con acquisti da grossisti legati alla camorra. Perciò le squadre di ronda avevano l’ordine di tenere d’occhio, con altre abitazioni, anche la sua; tuttavia con discrezione, a causa dei contatti erotici della Demaggi con ufficiali occupanti e considerando che, dopo il 25 luglio, quand’era stata sciolta l’OVRA
e ne era stato aperto l’archivio segreto, s’era scoperto che la donna ne era stata una prezzolata confidente e aveva riferito notizie politiche sfuggite a clienti fra le lenzuola, gerarchi compresi; si supponeva dunque che, dopo l’armistizio e l’occupazione tedesca, ella avesse iniziato una vendita di notizie agli ufficiali della Gestapo coi quali s’accompagnava.
Poco prima del fermo del sospettato, erano circa le 20 e 30 e non mancava che una mezz’ora al coprifuoco, transitando la camionetta della Polizia in piazzetta del Nilo, l’appuntato comandante aveva visto quell’individuo in abiti dimessi entrare senza suonare, per l’uscio lasciato accostato da qualcuno, nella casetta dove la donna viveva nell’unico appartamento al piano terra. Dando le spalle all’automezzo, l’uomo non s’era accorto del sopraggiungere della ronda. Superato l’ingresso, non aveva chiuso appieno la porta dietro di sé, ma l'aveva lasciata accostata. Il graduato aveva supposto che fosse implicato, come la Demaggi, nel mercato clandestino e avesse lasciato dischiuso per altri conniventi in arrivo: l’uscio non serrato rendeva improbabile trattarsi d’un cliente sessuale, senza contare l'abbigliamento da bassa manovalanza dell'uomo e le tariffe notoriamente elevate della prostituta. L’appuntato aveva ordinato al conducente di portarsi davanti alla casetta. Gli agenti erano scesi, a parte il guidatore, e s’erano introdotti nell’appartamento. L’individuo sospetto era stato sorpreso nell’ingresso, appena oltre l’uscio, in piedi accanto a Rosa Demaggi che, lamentandosi debolmente in stato di semi incoscienza, giaceva a terra con un ematoma insanguinato sulla nuca, conseguenza evidente d’un colpo contro una consolle, alla sinistra entrando, che presentava una macchia ematica. Rosa Demaggi era spirata pochi secondi dopo l’ingresso degli agenti. Ritenuto colpevole d’aver aggredito la donna, l’uomo in salopette era stato ammanettato. Il capo pattuglia gli aveva detto: “Ti sei introdotto con l’intenzione d’ucciderla e ti sono bastati pochissimi secondi per accopparla: era nell’ingresso ad attenderti, si fidava di te perché ti aveva lasciato aperto. Tu invece, inaspettatamente, senza darle il tempo di fuggire le hai sbattuto forte la testa contro il mobile per ammazzarla. Contavi di filartela subito dopo, infatti non avevi chiuso la porta entrando, per non perdere tempo nel riaprirla uscendo: te la saresti tirata dietro non appena fuori e tanti saluti, chi sa chi e quando avrebbe trovato il cadavere. Non avevi supposto che saremmo giunti noi: volevi far pensare a un incidente, ma ti è andata male.” Il graduato aveva supposto che l’individuo avesse ucciso con premeditazione per ragioni legate al mercato nero, forse per proprio diretto interesse, forse su incarico di terzi. Che si trattasse d’omicidio volontario era sostenuto dal fatto che l’uomo calzava guanti in lana nonostante la stagione ancora tiepida: al fine di non lasciare impronte, era stato spontaneo pensare. Sul momento il sospettato, in pieno rimescolamento mentale per l’inaspettato intervento degli agenti, non aveva trovato cosa rispondere. Poiché da vicino si poteva ben osservare che non solo portava abiti da manovale, ma ch’essi erano logori e piuttosto sporchi, l’appuntato s’era convinto che non potesse trattarsi d’un cliente sessuale della donna, e d’altronde l’uomo non aveva su di sé denaro, come s’era appurato frugandolo. Non aveva neppure carta d’identità, ma una patente di guida sì, da cui risultava essere nato a Napoli 42 anni prima, di abitare in vicolo Santa Luciella e di chiamarsi Gennaro Esposito, nome e cognome peraltro comunissimi in Campania e soprattutto a Napoli, che avrebbero potuto essere falsi, così come il permesso di guida; era infatti noto in Questura che la delinquenza, e in particolare la camorra, s’avvaleva di tipografi abilissimi nelle falsificazioni. Il capo ronda non aveva dato gran peso al documento.
Aveva chiamato la sala operativa della Centrale, attraverso la radio della camionetta, e riferito l'accaduto. La Sezione Delitti di Sangue aveva avvertito per telefono il centralino dell’obitorio, chiedendo di mandare a casa della morta, per i primi accertamenti, l’anatomopatologo in servizio, che per quel turno era il dottor Giovampaolo Palombella, un sessantenne dai lunghi e folti capelli grigi, tenuti regolarmente spettinati, alto, segaligno e, forse a causa del suo ultratrentennale chinarsi sui cadaveri da sezionare, un po’ curvo. Nello stesso tempo era stato inviato a casa della vittima un maresciallo maggiore, tal Bruno Branduardi, uomo basso, obeso e tranquillo prossimo alla pensione, perché ispezionasse, ascoltasse gli agenti della ronda e il medico e annotasse tutto sul proprio taccuino per riferire, al ritorno, al superiore di turno.
Il sottufficiale era giunto in piazzetta del Nilo sulla propria lenta motoretta modello La Piccola Italiana
che, smilza com’era, pareva mal sopportare il gravoso peso di quell’uomo pletorico. Aveva per prima cosa prestato orecchio agli agenti, poi al medico legale, ch’era arrivato un po’ dopo di lui, con due inservienti, sopra un furgone per il trasporto dei cadaveri. L’anatomopatologo aveva escluso il suicidio, aveva ritenuto possibile un incidente, dato che il colpo, a prima vista, non gli pareva essere stato violentissimo. Non aveva scartato però l’omicidio, riservandosi d’essere preciso dopo l’autopsia. Il maresciallo ne aveva preso nota, aggiungendo sul suo taccuino, a commento, che a suo parere non s’era trattato di disgrazia ma d’omicidio e che proprio il fermato, per lui, era l’assassino. In realtà s’era semplicemente allineato a quanto supposto e riferitogli dall’appuntato. Il cadavere era stato rimosso e caricato sul furgone dai portantini, per essere condotto all’obitorio dove sarebbe stato sottoposto ad autopsia. Da parte sua il Branduardi, dopo aver sveltamente ispezionato l’appartamento e constatato che non c’era nessuno, aveva ordinato agli agenti di mettere i sigilli alla porta d’ingresso, di portare il fermato in Questura e metterlo in guardina, in attesa che venisse affidato a un commissario per l’interrogatorio: in quel tempo la legge non prevedeva l’intervento d’un magistrato né sul luogo del delitto, né durante il colloquio inquisitorio del funzionario di Polizia con l’indiziato, che avveniva senza la presenza del suo avvocato. Il giudice istruttore subentrava se il commissario inquirente, avvalendosi del referto autoptico e avendo interrogato il sospettato, avesse ritenuto trattarsi d’un omicidio e ne avesse inviato rapporto alla Procura del Regno. In caso invece di disgrazia, la pratica, vistata dal vice questore, veniva semplicemente archiviata senza séguiti giudiziari.
Il Branduardi s'era accodato alla camionetta, perdendo però terreno per la bassa velocità della motoretta ormai vecchia e sfiatata. All’arrivo, mentre il fermato già era in camera di sicurezza, il maresciallo era salito al proprio ufficio nella Sezione Delitti di Sangue al secondo piano, stanza che divideva con un brigadiere e un agente dattilografo, e con flemma s’era preparato un caffè di guerra, un surrogato, con la propria macchinetta napoletana che teneva nell’armadio insieme a un fornellino elettrico a incandescenza. Se l’era sorbito bollente dopo averlo addolcito con una pastigliuccia di saccarina, non perché diabetico ma in quanto lo zucchero, dall’entrata in guerra, era introvabile per i comuni mortali. S’era quindi fumato una sigaretta Serenissima Zara con calma altrettanto celeste, assaporandola fin quasi all’esaurimento della cicca che, per le ultime due boccate, aveva trattenuto infilzandola con uno spillo, come in quei tempi di carestia e sigarette senza filtro non pochi fumatori usavano fare; e finalmente, a passo lemme, aveva portato il foglietto col rapporto, non più di venti metri sullo stesso piano, a uno dei vice comandanti della Sezione Delitti di Sangue, un certo commissario capo Riccardo Calvo ch’era di turno quella notte fin alle ventiquattro. Alle ore zero e pochi secondi il Branduardi se n’era andato a casa a dormire e, poco dopo, pure il Calvo dopo aver lasciato il rapporto del maresciallo sulla scrivania del suo pari grado subentrante, il dottor Giuliano Boni.
L’uomo in salopette aveva seguitato a starsene chiuso in camera di sicurezza.
Finalmente, su ordine del commissario capo Boni, il caso Rosa Demaggi era stato rifilato a un quasi imberbe vice commissario montato in servizio a mezzanotte, il dottor Vittorio D’Aiazzo, da poco meno d'un anno attivo in Pubblica Sicurezza e, fin dal primo giorno, assegnato alla rognosa Sezione Delitti di Sangue.
Erano circa le 3 di notte del 27 settembre 1943 e l’insurrezione che la Storia ricorda come Le Quattro Giornate di Napoli stava per scoccare: la pignatta dell’angariatissima città stava ribollendo e la temperatura era salita ormai a tale grado che impossibile sarebbe stato, per il tedesco occupante, impedirne l’eruzione ardente.
Capitolo 2
Il sentire del popolo di Partenope era rimasto oscuro allo sprezzante invasore nazista e la paura che questi aveva inteso diffondere in città s’era risolta in bollore d’animo e desiderio di ribellione. Facimmo ‘a uèrra a chilli strunzi zellosi
era ormai il sentimento di numerosi napoletani, nella sensazione che, san Genna’ ajutànno
! ci si sarebbe affrancati e, finalmente, la pace sarebbe stata vera-verissima e non più l’illusione nata e morta un paio di mesi prima:
Il 25 luglio l’Italia aveva esultato per la caduta nella notte del regime, apparsa definitiva con Mussolini esautorato dallo stesso Gran Consiglio del Fascismo e fatto arrestare dal re, e col nuovo Governo Badoglio non più fascista, anche se non democraticamente eletto; ma era stato anzitutto l’abbaglio che il conflitto fosse finito a far gioire la nazione. Tuttavia, ben presto nel Paese s’erano alzate lamentazioni che a Napoli avevano presentato toni pittoreschi lungo i vicoli e all’ombra dei bassi, come: Chillo capucchióne d’o nuvièllo Càpo ‘e Guviérno
, ‘o maresciallo d’Italia Badoglio Pietro, ‘o gran generalone! ha fatto di’ a ‘a ràdio, tòmo, tòmo
: “La guerra continua”: strunz’ e mmèrda! C’erano stati, poi, coloro che avevano puntualizzato: Nossignori, strunzi noi ati a penzà che ‘nu maresciallone vulisse ‘a pace!
Ma va’ ffa ‘n ‘c… Con l’armistizio di Cassibile, siglato fra l’Italia e gli angloamericani il 3 di settembre e che avrebbe dovuto restare segreto fin al riassetto delle forze armate italiane ad argine del vendicativo ex alleato, ma era stato reso noto il giorno 8 da vanagloriosi generali vincitori, era piombato sull’Italia, attraverso il Brennero, un male peggiore di prima: molte nuove, agguerrite e astiose divisioni germaniche s'erano aggiunte ai reparti tedeschi già presenti sul territorio. “Perché mai”, si chiedevano gl’italiani più provveduti, “i governanti e i capi militari non hanno saputo predisporre a tempo un piano d’emergenza? Nonostante la resa al nemico fosse da tempo probabile? Con forze dell’implacabile ex alleato già in casa?” Dopo l'8 settembre il re e i suoi ministri avevano saputo solo fuggire nel sud, a Brindisi, approfittando del fatto che la 1a divisione aerotrasportata inglese stava per prendere quella città la quale, a differenza delle altre, era sgombra o quasi da truppe tedesche, e contando sul fatto che gli angloamericani, conquistata la Sicilia, stavano invadendo il resto delle regioni meridionali della Penisola
. Ansimanti, il sovrano, i suoi segretari di Stato e il generale Mario Roatta, difensore mancato di Roma abbandonata all’iniziativa disordinata e inutile dei comandanti di reparto, avevano lasciato la Capitale per porre Trono, Governo e Alti comandi a Brindisi, sotto la protezione degli ex nemici, lasciando le truppe italiane sui vari fronti esteri e in Italia senza ordini, in balia del possente esercito germanico. Dopo l’annuncio ufficiale dell’armistizio da parte italiana, dato alla radio personalmente da Badoglio alle 19 e 37 minuti dell’8 settembre, il tedesco, grazie ai rinforzi giunti rapidissimi, era rimasto padrone incontrastato dalle Alpi fin alla città di Napoli compresa, mentre la provincia di Salerno era divenuta zona di combattimento per lo sbarco angloamericano del giorno 9. La collera dei partenopei, già calda per la guerra patita, era divenuta ardente: troppe ne avevano dovute sopportare nei tre anni e più dalla proditoria e improvvida entrata nel conflitto del regime, il 10 giugno 1940, dietro alla Germania nazista; Napoli era stata bombardata sistematicamente dagl’inglesi e poi anche dagli statunitensi, ben centocinque incursioni fin all’armistizio, tutte andate a segno rendendo in macerie edifici su edifici con gran numero di morti, feriti e mutilati e torme di famiglie senza casa. Non un solo quartiere era stato risparmiato, anche perché i dirigenti politici e militari erano stati incapaci d’approntare adeguate difese antiaeree, affidate quasi del tutto, in modo improvvisato, alle navi da guerra alla fonda nel porto; e poi, la fame! quella fame cupa e sorda che piega le gambe; ed essendo sfumata l’illusione di pace del 25 luglio, ecco altri nugoli di bombe sulla città e la carestia assoluta, e malattie con ulteriori morti per deficienza di medicinali. Fin dal 9 settembre Napoli aveva patito guasti materiali da parte germanica, fra i quali gravissimi danni al porto, e sofferto retate e fucilazioni non solo di militari italiani sbandati ma pure di civili. Anche i fascisti, un paio di settimane dopo l’8 settembre, sia pur in subordine avevano preso possesso della città, risorti dalle tombe politiche e assurti al neonato Stato Nazionale Repubblicano – presto Repubblica Sociale Italiana – costituito il 23 di quel mese da Hitler in persona, con a capo il nolente ma rassegnato Mussolini che, il 12, paracadutisti germanici avevano liberato dal rifugio-albergo di Campo Imperatore sul Gran Sasso, domicilio coatto dove il re l’aveva relegato.
La tradizionale durezza bellica teutonica era divenuta, se possibile, ancora più barbara, perché eccitata da isolati attacchi sferrati da cittadini col supporto di marinai delle navi alla fonda della Regia Marina: s’era trattato d’una primissima, sporadica resistenza spontanea, non ancor collegata ai partiti avversari del nazifascismo, una ribellione iniziata in via Santa Brigida dove, nella mattina del 9, una trentina di residenti aveva assalito una squadra della Wehrmacht, dopo che uno di quei soldati, come al tiro a segno d’un parco divertimenti, aveva sparato col proprio fucile d’ordinanza Mauser Kar 98k all’inerme garzone dodicenne d’un negozio, che si trovava sull’uscio dell’esercizio a prendere un po' di sole.
Aveva dato il la a quella compagine d'umiliati partenopei il giovane vice commissario che abbiamo già incontrato di sfuggita, il dottor Vittorio D’Aiazzo, il quale se ne stava transitando a piedi nei pressi quando il soldato tedesco aveva mirato e fatto fuoco contro il ragazzino: il giovane ufficiale della Pubblica Sicurezza, indignatissimo, aveva sparato senza mirare, da dietro un angolo, nel mucchio teutonico con la sua Beretta M34 d’ordinanza, svuotandone il caricatore e uccidendo due soldati, S’era quindi eclissato attraverso un vicolo laterale, non tanto per paura del nemico ma per timore di noie, o peggio, da parte dei superiori.
Mentre si dileguava, coloro che della trentina d'esacerbati civili presenti avevano in tasca coltelli, cioè quasi tutti, li avevano estratti e la massa, accesa al calor bianco dalla vista dei cadaveri nemici e dall'immagine d’o sbenturàto
guaglio’ che, colpito all’arteria femorale, stava celermente spirando, s'era gettata sul resto della squadra tedesca cacciando urla belluine. Per primo il soldato sparatore era stato sgozzato, sbuzzato ed evirato da tre indignati, un milite s'era ricevuto un pugno sul naso da un assalitore privo di lama e aveva avuto, da un altro alle sue spalle, un colpo di coltellaccio che l'aveva lasciato ferito orizzontalmente alle chiappe; quasi tutti gli assaliti avevano sofferto tumefazioni e lacerazioni a braccia e volto, uno, peggio, aveva perso il naso. Nessun germanico era riuscito a sparare un sol colpo contro l'orda inselvatichita e presto, sergente in testa, la squadra era fuggita abbandonando sull'acciottolato la propria boria. I fucili e le bombe a mano degli ammazzati e i fucili lasciati a terra dai feriti più gravi erano stati raccolti e nascosti nelle case. Prestissimo sarebbero serviti ad affrancare la città. I tre cadaveri erano stati portati in bassi, qui sezionati, i brandelli erano stati avvolti in stracci e sepolti in vari posti della zona; si sarebbe sussurrato in seguito, vero o falso? che però qualche bel pezzo di natica fosse finito arrosto in pance denutrite. La via era stata lavata dalle donne degl'impavidi ribelli, con gran lena, tanto che mai più sarebbe stata così linda.
Nello stesso tempo in altra zona di Napoli, del tutto indipendentemente, un gruppo d’improvvisati combattenti aveva assalito un manipolo di guastatori tedeschi, che stava cercando d'occupare la sede della compagnia telefonica, e l’aveva messo in fuga. Il plotone germanico s’era vendicato catturando più in là e fucilando due carabinieri in servizio di ronda. Non molto dopo, un’intera compagnia tedesca d'assaltatori era sopraggiunta davanti al palazzo dei telefoni e, presto, aveva avuto ragione degl’insorti che lo presidiavano. Eppure, contro i propositi dei nazisti, era montata ancor più la collera degli umiliati napoletani e, il giorno seguente, ai piedi della collina di Pizzofalcone tra la piazza del Plebiscito e i giardini sottostanti, c’era stata una vera e propria battaglia, accesa da alcuni marinai, coi loro moschetti ’91 e bombe a mano, e alimentata da molti civili armati di mitra MP80 e granate model 24, sottratti il giorno precedente agli occupanti, e di improvvisate bottiglie molotov. I ribelli avevano impedito il passaggio di un’intera colonna di camion e camionette germanici. C’erano stati sei morti, tre marinai italiani che avevano combattuto in prima fila e altrettanti soldati tedeschi, e inoltre molti feriti da entrambe le parti.
Pesanti provvedimenti e gravi rappresaglie erano seguiti da parte tedesca, su ordine del fresco comandante della città colonnello Walter Scholl che, il giorno 12, aveva assunto ufficialmente il potere assoluto sulla piazza. Un suo proclama aveva imposto la consegna delle armi, forze di pubblica sicurezza a parte, il coprifuoco alle ore 21 e lo stato d’assedio per l'intera città, mentre erano stati fucilati non solo i militari e i civili caduti prigionieri, ma diversi cittadini rastrellati a bella posta.
I tedeschi s’erano scatenati del tutto dopo il giorno 12, saccheggiando, distruggendo e incendiando; per prima era stata data alle fiamme l’università, dopo avervi fucilato innanzi un inerme marinaio italiano costringendo i cittadini presenti non solo ad assistere all’esecuzione, ma ad applaudirla. Fino al 25 settembre, sebbene dopo i primi giorni la città non avesse più agito apertamente contro gli occupanti, le ronde tedesche avevano catturato chiunque, non essendo poliziotto, fosse stato sorpreso per via in divisa italiana o, essendo in borghese, semplicemente fosse sembrato sospetto.
Napoli aveva taciuto ma sfrigolando e preparandosi all’insorgenza. In particolare, militari sbandati erano stati raccolti a uno a uno da membri dei partiti antinazifascisti e nascosti e addestrati alla guerriglia, molti entro i locali sotterranei del liceo Sannazaro, prima sede della neonata resistenza napoletana.
Il giorno 25 settembre, lo stesso in cui l’Italia aveva sofferto da parte americana due gravissimi bombardamenti su Bologna e Firenze, era stata emanata in Napoli un’ordinanza che stabiliva la coscrizione, per mansioni di fatica a favore dei germanici, di tutti i cittadini in età di lavoro. Era stata la miccia della sommossa che si sarebbe alzata pochissimi giorni dopo, in perfetta antitesi alle intenzioni intimidatorie tedesche. I manifesti del decreto erano stati affissi ai muri già il mattino presto della domenica 26, giorno antecedente quello delle iniziali vampe dell’insorgenza.
Se l’ordine sostanziale di reclutamento era stato del colonnello Scholl, quello formale era stato firmato dalla mano italiana del prefetto Domenico Soprano che ad agosto, su nomina del Governo Badoglio, aveva preso il posto del dimissionato prefetto fascista Vaccari. Il Soprano era uomo d’ordine, anticomunista e antisocialista e avversario di possibili azioni violente da parte del popolo, anche se non era fascista ma liberale: non certo un demoliberale alla Gobetti, ma un aristocratico all’antica. Più per la sua ripulsa verso le masse popolari che per soggezione ai tedeschi egli aveva firmato il decreto di coscrizione al lavoro: temporeggiare per mantenere la calma era stato il suo immediato obiettivo. Pochi giorni prima di quel 26 settembre, dopo che c’erano stati contatti fra l’intelligence dell’US Army e i dirigenti dei partiti antifascisti napoletani, proprio in vista di un’auspicata sollevazione di Napoli, il prefetto Soprano era stato avvicinato da esponenti del neonato Fronte Nazionale di Liberazione – poi Comitato di Liberazione Nazionale – da poco fondato con sede centrale a Roma, composto dal Partito d’azione, dal Partito liberale, dal Centro democratico cristiano, dalla Democrazia del lavoro, dal Partito socialista di unità proletaria e dal Partito comunista. Avevano premuto su di lui perché cooperasse con la nascente opposizione tramite le forze di Polizia che dirigeva, offrendogli tutto l'appoggio possibile. Il prefetto però, sempre perché avversario del socialcomunismo e timoroso di qualsiasi moto rivoluzionario, aveva preferito la via della prudenza, limitandosi a dialogare politicamente, in segreto, coi moderati dirigenti liberali Enrico De Nicola e Benedetto Croce: senza scoprirsi.
Tanto Domenico Soprano quanto Walter Scholl avevano fatto male i conti. Poiché centocinquanta persone soltanto s'erano presentate ai germanici entro il termine stabilito dal bando, gli stessi, nel corso del pomeriggio di domenica 26 settembre e delle prime ore notturne, avevano preso a rastrellare selvaggiamente Napoli radunando 8000 inermi cittadini, anche uomini attempati e ragazzi tredicenni. I tedeschi avevano fatto scoccare la scintilla della ribellione accendendo gli animi dei famigliari e parenti dei rastrellati, smaniosi di liberarli. La mattina presto di lunedì 27 settembre c’erano stati i primi scontri, avviati non solo da militari italiani rimasti fin ad allora nascosti nei sotterranei del liceo Sannazaro e in case private, ma pure da un certo numero di civili, anche se la vera e propria sollevazione popolare di Napoli sarebbe esplosa il giorno seguente, con un dilagare per le strade e le piazze di frotte di partenopei armati d’ogni classe sociale, dagli ultra popolani agli intellettuali, presenti anche ragazzini dodicenni e giovani donne.In quegli anni in Italia ci si dava del voi e non del lei come oggidì. Il lei era stato vietato dal fascismo fin dalla metà degli anni ’30 del XX secolo, essendo stato giudicato un pronome allocutivo di origine spagnola e non italiana - in realtà era usato sicuramente, quanto meno verso i potenti, già nel XV secolo, anche se tal uso s’era generalizzato solo dal XVI in poi, effettivamente per influsso dello spagnolo -; per di più l’uso del lei era stato vietato, non comprendendo evidentemente il ridicolo dell’osservazione, perché considerato non degno della virilità fascista essendo pronome allocutivo di genere femminile.
Da sempre peraltro i napoletani si erano dati del voi, sia nel loro dialetto, sia traslando in italiano.
Capitolo 3
Il giovane vice commissario giustiziere di tedeschi e incaricato d’inquisire l’uomo in salopette era un ventiquattrenne, napoletano di nascita e per discendenza materna. Portava fitti capelli neri naturalmente ricci, tenuti corti alla militare secondo il regolamento di quegli anni. Era di non alta statura, un metro e sessantacinque, ma ben proporzionato e robusto. S’era laureato in giurisprudenza alla Federico II di Napoli con lode e dignità di stampa e, se di mente era brillante, d’animo era pulito, formato in famiglia e in collegio secondo classici principi etici, in sostanza i precetti dei 10 comandamenti giudeocristiani. A causa però della verde età, che poche disillusioni gli aveva fatto soffrire per il momento, Vittorio D’Aiazzo era un poco immodesto. Abitava col papà, Amilcare D’Aiazzo tenente colonnello dei Regi Carabinieri, e con la mamma, signora Luigia-Antonia diplomata maestra elementare ma casalinga, nel loro appartamento di proprietà, non situato in zona prestigiosa come sarebbe piaciuto alla famiglia, per esempio non in via Caracciolo o sulla Riviera di Chiaia, ma nel popolare rione Sanità, in via San Gregorio Armeno su cui s’affacciavano abitazioni alla portata dei non pingui stipendi, in quell'epoca, e dei non eccelsi risparmi d’un ufficiale superiore dell’Arma Benemerita. Al momento Vittorio viveva da solo nell’alloggio, a parte una donna a mezzo servizio, ché la mamma era sfollata in campagna all’inizio della guerra e il padre, da un paio di settimane, aveva passato le linee nottetempo, benché sessantunenne, quindici anni più della consorte, per non restare, di fatto, agli ordini dei tedeschi occupanti e per raggiungere il proprio sovrano. Aveva fin a quel momento prestato servizio nel 7° Gruppo Provinciale Carabinieri di Napoli, quale capo della Sezione Coordinamento Investigativo Provinciale. I coniugi D’Aiazzo avevano due figli maschi. Mentre erano orgogliosi di Vittorio, non potevano stimare l’altro, Emanuele, che fin da bambino era stato un indolente: dopo bocciature diverse, preso il diplomino delle elementari soltanto a quattordici anni e col minimo dei voti, aveva abbandonato i non sudati studi all’inizio del primo anno della scuola complementare per l'avviamento al lavoro, cui il padre s’era rassegnato a iscriverlo perché, a differenza del ginnasio
, non prevedeva un esame d’ammissione. Sedicenne, era scappato da casa, senza poter essere rintracciato dalla forza pubblica, dando notizie di sé solo dopo anni, una volta maggiorenne
, con un’unica cartolina illustrata, indirizzata alla mamma, spedita dalla Svizzera nel maggio 1940, con poche parole di saluto. Non essendosi Emanuele presentato alla visita di leva, era stato considerato renitente e condannato in contumacia alla prigione dal Tribunale Militare di Napoli; e scoppiata la guerra, era stato considerato disertore. Il tenente colonnello D’Aiazzo aveva avuto un danno d’immagine da quel figlio e temeva che, a causa sua, non sarebbe più salito di grado, nonostante gli ampi meriti personali. Di più Vittorio, per le colpe del fratello, non aveva potuto seguire le orme paterne ed entrare nell’Arma, come avrebbero voluto tanto lui che i genitori; a quei tempi infatti, non solo i personalmente disonesti, ma anche coloro che avevano ascendenti o parenti non assolutamente specchiati non potevano presentare domanda per la Benemerita. Amareggiato ma non rassegnato del tutto, Vittorio s’era laureato e aveva partecipato al concorso per vice commissario nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, ente che richiedeva solo l’integrità personale dell’aspirante e non pure dei suoi congiunti. Aveva superato brillantemente la prova e, al termine della successiva scuola di specializzazione professionale, era risultato il primo in classifica, con buone speranze, dunque, d’essere esaudito nella scelta della destinazione, la sua Napoli; e proprio nella domestica città era stato assegnato.
Dopo aver letto il breve rapporto del maresciallo Branduardi, il vice commissario D’Aiazzo s'era diretto alle camere di sicurezza, al piano terra, e vi aveva osservato la figura del sedicente Gennaro Esposito. Era sceso quindi nell’umido archivio sotterraneo e vi aveva controllato se qualcuno con quei dati anagrafici risultasse schedato e se le sue foto, di fronte e di profilo, corrispondessero alla fisionomia del prigioniero. Aveva trovato diverse cartelle segnaletiche con gli stessi nome e cognome, ma tutte riguardanti persone di lineamenti differenti da quelli del presunto assassino. Tornato nel proprio ufficio, s’era fatto condurre il fermato.
L’aveva inquisito con l’aiuto del proprio assistente brigadiere Marino Bordin che, seduto al proprio tavolino, aveva battuto le domande del superiore e le risposte dell’interrogato sulla macchina per scrivere dell’ufficio, un’obsoleta Olivetti M1 nera modello 1911.
Il Bordin era un veneziano biondo robusto, alto un metro e ottanta. Quarantacinquenne, serviva in Pubblica Sicurezza da un quarto di secolo e aveva moglie e due bambini, che aveva sfollati in una casa colonica nella campagna napoletana, sacrificando all’agricoltore ospitante i due terzi del proprio stipendio e rassegnandosi, col rimanente, a mangiare e dormire in caserma.
Per ore l’indagato, senza demordere, aveva detto e ripetuto, in un corretto idioma che faceva pensare avesse frequentato almeno le classi elementari, assai severe a quel tempo, d’essere un cuoco disoccupato, d’abitare, così com’era scritto sulla sua patente, in vicolo Santa Luciella e che stava rientrando a casa quando aveva visto la porta di casa della morta accostata e aveva udito gemiti provenire dall’interno: per mero altruismo era entrato, chiedendo permesso, aveva visto nell’atrio la donna a terra che continuava a gemere e, avendo adocchiato un apparecchio telefonico su di una parete, aveva deciso di chiamare un’autolettiga; ma proprio in quell’attimo era entrata la ronda di Pubblica Sicurezza che l’aveva ammanettato.
Dài e ridài, poco dopo le 7 del mattino il vice commissario aveva finalmente ottenuto un dato nuovo, che l’uomo era un frequentatore abituale della prostituta e ch'era entrato da lei, essendo atteso, per avere uno svelto rapporto sessuale, così da andarsene presto e raggiungere casa propria prima del coprifuoco. A domanda, aveva precisato che aveva fissato telefonicamente l’appuntamento da un bar, come tante altre volte. Richiesto di recitare il numero telefonico della Demaggi, aveva detto che non se lo ricordava più e, allo scetticismo manifestato dal D’Aiazzo, aveva giustificato l’amnesia con lo stato di subbuglio mentale dovuto alla situazione. Per il resto non aveva cambiato versione ribadendo che, una volta entrato attraverso l’uscio lasciato socchiuso apposta per lui in seguito alla telefonata, aveva visto la donna a terra e s’era sùbito risolto a chiamare soccorso con l’apparecchio telefonico dell’appartamento, quand’ecco che la pattuglia era sopraggiunta e l’aveva fermato.
Come già gli agenti della ronda, nemmeno il vice commissario aveva potuto credere che l’uomo fosse un cliente dell’esosa mondana, avendo valutato il suo abbigliamento modesto e mal ridotto e l’assenza di denaro nelle sue tasche. Considerando che l’uscio era stato lasciato aperto verosimilmente proprio per lui, l’aveva supposto un complice nel mercato nero. L’aveva dunque accusato d’averla ammazzata per sopraggiunti contrasti: “Confessalo e ti mando a dormire!”
“Non è vero niente, s’è trattato sicuramente d’un incidente avvenuto prima ch’io entrassi”, aveva negato l’altro.
“Se non eri un complice in disaccordo, allora eri stato mandato a ucciderla da un concorrente”, aveva premuto il funzionario.
“Signor dottore, vi
dico ancora che non è vero!” s’era acceso l’uomo abbandonando l’atteggiamento docile che aveva tenuto fin a quel momento.
Non richiesto, il brigadiere Bordin era scattato: “Busòn!
Porta rispetto al dottore o ti riempio di calci dove te lo fai ficcare!”
Il vice commissario non ammetteva villanie e l’aveva redarguito: “Marino, i calci e l’insulto te li tieni per te.” Aveva ripreso: “Gennaro, sempre che tu ti chiami davvero Gennaro Esposito, e sta’ sicuro che controlleremo all’Anagrafe domani… no, stamattina, vista l’ora, sentimi bene: anch’io, come te, avrei voglia di concludere, dunque ti faccio una proposta” – l’uomo aveva alzato la soglia d’attenzione visibilmente, semi schiudendo la bocca mentre le pupille gli si dilatavano un poco –: “Se ti confessi colpevole di omicidio preterintenzionale, il che significa che hai ucciso andando oltre l’intenzione che avevi…”
“…lo so.”
“Allora senti: potresti ad esempio dirmi che non avevi soldi e che la vittima non voleva concedersi a credito, per cui in un irrefrenabile impulso d’ira le avevi dato una spinta, senza volerla ammazzare ma, disgraziatamente, lei cadendo era rimasta lesa a morte; insomma, mi hai capito: in questo modo davanti al plotone d’esecuzione, non ci finisci
, ti fai solo un po’ di galera. Se invece io scrivo nel mio rapporto per il giudice istruttore che sospetto tu sia il sicario d’un qualche borsanerista della camorra che ha voluto eliminarla, oppure un diretto concorrente della donna al mercato nero che ha voluto farla fuori per sempre, tu sei già bell’e fucilato.”
L’uomo, pur se più stanco del vice commissario, non aveva confessato: “Non solo vi ripeto un’altra volta che non sono un assassino e, a quanto ne so io, che la donna è morta per un incidente avvenuto prima ch’io entrassi da lei, ma adesso vi dico pure che sono un sergente maggiore artigliere e che ho passato le linee raggiungendo Napoli ieri sera.”
“Hm… dimmi di più.”
“Sono anche cuoco, ero in servizio come direttore di cucina nel circolo ufficiali del 3° battaglione, 1° reggimento Artiglieria Costiera, di stanza a un cinque chilometri a nord di Paestum, in provincia di Salerno.”
“Lo so dov’è Paestum… va beh, supponendo che tu m’abbia detto adesso la verità, è nel tuo stesso interesse che noi si controlli la tua identità militare e perciò dimmi della scuola allievi sottufficiali da cui vieni e da quale corso”: in realtà, nel caos seguito all’armistizio quella verifica sarebbe stata probabilmente impossibile e il D’Aiazzo lo sapeva, ma aveva contato sul fatto che l’altro, qualora gli avesse mentito, si sarebbe scoperto.
L’uomo non s’era scomposto: “La mia carriera è partita dalla gavetta: a ventotto anni, dopo aver perso il posto di aiuto cuoco in una trattoria…”
“…cos’avevi combinato?”
“...ma niente di male! Il locale aveva chiuso perché, come dicevano i padroni, erano arrivate le ultime conseguenze della crisi del ’29.”
“Va beh, va’ avanti.”
“Avevo cercato lavoro altrove ma trovato niente: nessuno assumeva, semmai licenziavano. Allora, per non pesare su mia madre ch’era rimasta vedova e faticava facendo le pulizie in negozi e cucendo e ricamando in casa per estranei, alla fine m’ero arruolato volontario, sperando di fare carriera e diventare sottufficiale: sei anni prima ero stato congedato dal servizio, con onore, col grado di caporale, che mi era stato riconosciuto alla riafferma; e siccome ero stato già nelle cucine durante la leva, dopo il corso d’aggiornamento su certi cannoni m’avevano di nuovo spedito davanti alle pignatte, a parte le periodiche esercitazioni di tiro con l’artiglieria, il fucile e la pistola; e così è stato per tutta la mia carriera militare, prima da caporalmaggiore, quindi da sergente e, finalmente, da sottufficiale
: sergente maggiore direttore della cucina del circolo ufficiali. Dopo l’armistizio e lo sbarco degli ex nemici
sulle nostre coste, mi sono trovato allo sbando coi commilitoni, preoccupato di non incontrare né angloamericani né tedeschi. Mi sono imboscato, mangiando frutta e verdura portate via agli orti e, le poche volte che mi ospitavano in cascine, anche pane, latte e uova; ma i contadini, o almeno quelli che ho incontrato io, son gente interessata, mi hanno chiesto senza eccezioni un compenso, prima in soldi, e ho dato loro, a mano a mano, quanto mi restava dell’ultimo stipendio, poi, finito il denaro, ho dovuto lasciare il mio orologio: era d’acciaio, ma di marca; e all’ultimo purucchio
ho mollato la mia medaglietta di san Genna’ con catenella, tutt’e due in oro 18 carati, dono dei miei per la Prima Comunione, in cambio del camisaccio e della tuta da lavoro che ancora indosso. Mi sono messo in borghese e ho gettato la piastrina militare di riconoscimento e anche i documenti militari, perché noi di carriera l’abbiamo non solo d’altro colore ma con scritto sopra che siamo appunto militari e anche il nostro grado…”
“…lo so”
“Già, pure per voi è così. Ho buttato la carta d’identità e la patente militari tenendo solo la patente civile e, non più in divisa, mi sono diretto alla mia Napoli, sono riuscito a passare la linea del fronte e, ieri sera, sono entrato in città. Muovendomi prudentemente anche se ero in borghese e avevo con me un documento, sono giunto in piazzetta del Nilo, che non è lontana dall’alloggetto di mammà e mio nel vicolo Santa Luciella; e, per colpa del mio buon cuore, dopo quant’avevo già passato, ho ancora avuto l’impulso d’aiutare quella donna che gemeva e… eccomi qui, proprio quand’ero ormai vicinissimo a casa.”
“Come mai sul tuo permesso di guida non è segnato il tuo domicilio nella zona di Paestum?”
“Occupavo una stanza in caserma, assieme a un altro sergente maggiore anch’egli scapolo, non avevo un’abitazione esterna: mai ho considerato le caserme come casa mia e mai m’è venuto di far togliere l’indirizzo di Napoli: solo sulla carta d’identità e sul permesso di guida militari facevo variare, perché era obbligatorio, a parte il fatto che sulla patente civile avrei dovuto far cambiare sovente l’indirizzo dalla Motorizzazione
, dato che mi trasferivano ogni pochi anni; e invece la carta e la patente militari, me le rifacevano direttamente nel nuovo reparto; e poi, dopotutto, a Napoli da mammà tornavo ogni volta che andavo in licenza.”
“Sappi che andremo in vicolo Santa Maria a controllare se ci abita davvero tua madre e se altre persone ti conoscono.”
“…e io vi ringrazio, signor commissario, perché è proprio là che sta mammà e potrete avere conferma di me da lei e pure dai vicini; mi raccomando, però, di tutto cuore: non spaventatemi mammà, ditele, per piacere, che vi ho incaricato io di salutarmela dato che non ho potuto venire di persona per ragioni di servizio.”
“Se troviamo tua madre, non te la spaventiamo e le parliamo come tu desideri.” A questo punto, però, il vice commissario gli era stato di nuovo addosso: “Prima avevi tentato di farmi credere d’aver avuto con la Demaggi un appuntamento galante prezzolato e poi hai ammesso che non era vero; allora dimmi: se la vedevi per la prima volta, come facevi a sapere che quella donna era un prostituta?”
Non s’era scomposto: “L’avevo sentito dal vostro capo ronda che ne aveva parlato coi suoi davanti alla morta.”
“Controllerò. Adesso dimmi ancora una cosa” – il D’Aiazzo aveva lasciato la domanda per ultima, per scoccarla quando l’inquisito fosse stato stanchissimo –: “Perché mai portavi guanti di lana in questa stagione? Per non lasciare impronte, non è vero?”
“…ma no, signor commissario”, non s’era preoccupato l’altro, “il motivo è semplice, li indosso ormai da tempo, li avevo anche in servizio, su permesso del capitano: soffro di dolori alle dita delle mani e anche al palmo sinistro.”
“Hm…”
“…ma sì, per l’umidità delle cucine nel corso di tanti anni, tra vapori di pentole e acqua dei lavaggi delle marmitte, come mi aveva spiegato il tenente medico, ed era stato lui a dirmi di portare i guanti.”
Stremato l’uomo e stracchi i due poliziotti, a un ordine del vice commissario il presunto sergente maggiore Gennaro Esposito era stato scortato in camera di sicurezza dal brigadiere Bordin.
Coi soli dati raccolti Vittorio D’Aiazzo non aveva potuto formarsi un’idea certa: restavano per lui contemplabili tanto l’ipotesi d’un incidente quanto quella d’un omicidio e questo non necessariamente perpetrato dal fermato; nel caso però di sua colpevolezza, il movente poteva trovarsi nella concorrenza fra borsaneristi, se l’identità e in particolare la posizione nell’Esercito del sedicente Esposito non fossero state confermate, mentre in caso contrario sarebbe stato verosimile un diverso motivo. Peraltro, se l’anatomopatologo avesse stabilito essersi trattato d’assassinio, l’inquisito, sebbene non avesse confessato, sarebbe stato trasferito alla Casa Circondariale di Poggioreale quale sospetto, mentre parallelamente il vice commissario avrebbe dovuto stilare e trasmettere alla Procura del Regno una relazione contenente sia le conclusioni del medico legale, sia le notizie raccolte dallo stesso D’Aiazzo durante l’interrogatorio. Sul suo rapporto il giudice istruttore avrebbe deciso se aprire un procedimento contro il sospettato oppure farlo scarcerare per insufficienza di prove.
Non mancava più molto alle 8 del mattino e il giovane funzionario stava per terminare il suo turno; tuttavia, prima di tornarsene a casa intendeva ancor ordinare al brigadiere d’andare in vicolo Santa Luciella a controllare se ci vivesse davvero la madre dell’indagato e, in questo caso, se ella riconoscesse il figlio nella foto della patente e se confermasse ch’egli era davvero un sergente maggiore d’artiglieria. Il vice commissario non aveva però in programma d’aspettare il ritorno del sottoposto, ne avrebbe ascoltato la relazione il giorno seguente; tanto, prima che giungesse al suo ufficio il verbale dell’anatomopatologo sarebbero passati almeno due o tre giorni, duranti i quali il fermato se ne sarebbe rimasto chiuso in guardina.
Il Bordin, dopo aver fatto ridurre l’inquisito in cella, era tornato dal D’Aiazzo. Entrato in ufficio gli aveva detto: “Signor commissario, secondo me quell’Esposito o presunto tale è stato mandato dalla camorra ad ammazzare la Demaggi per due possibili motivi: o per ragioni di concorrenza a borsa nera, o perché quella lurida puttana non voleva più pagare la tangente…”
“…Marino, quella donna è morta e i defunti non s’insultano”, l’aveva ammonito il giovane superiore, “e comunque non sono convinto che l’indiziato sia un assassino.”
“Scusatemi se mi permetto, ma penso… beh, che voi siete sempre troppo buono: se noi gli menavamo qualche colpo allo stomaco coi sacchetti di sabbia…”
“…che non lasciano il segno?”
“Prudenza lo vuole; e state sicuro che quel delinquente si sarebbe dichiarato colpevole e pure camorrista e chi sa cos’altro. Invece così…”
“…invece così non ho rischiato di far confessare un innocente, a parte che se ti vedessi mollare sacchettate a qualcuno… mi hai capito, Marino?”
“Eeh….”
“Ci penserà il giudice istruttore, semmai, a fargli ammettere la colpevolezza, sempre che il medico non ci dica che s’è trattato d’un incidente così ch’io archivi la pratica e liberi quell’uomo.”
“Già, può darsi; però, parlando in generale, voi, signor commissario, siete forse l’unico qui a non mollare almeno qualche ceffone agl’interrogati. Il fu dottor Perati che servivo prima di voi faceva confessare tutti.”
Nell’ardore dell’età, non disgiunto da quel pizzico di presunzione che permaneva in lui, era sfuggito al vice commissario, istintivamente nella lingua partenopea che usava in famiglia: “Tu si’ ‘nu fésso.”
“Cosa?!” era divenuto paonazzo il sottufficiale.
Il superiore s’era parzialmente emendato: “Va bene, Marino, ritiro il fesso, però sbagli a parlarmi senza riguardo solo perché ho la metà dei tuoi anni. Sta’ accorto, perché se ricapita, ti punisco.”
Il Bordin aveva ritenuto saggio scusarsi, sia pur a denti stretti: “Perdonate, signor commissario, è stato tanto per dire, non volevo criticarvi.”
Se Vittorio D’Aiazzo, col tempo, avrebbe acquisito appieno l’umiltà grazie alle metaforiche sberle della vita, al momento voleva ancor essere lui a pronunciare l’ultima parola: “Va bene, ma d’ora in poi pensa a quello che dici, prima di dire quello che pensi.”
L’uomo aveva ritenuto saggio irrigidirsi sull’attenti: “Signorsì.”
“Sta’ pure sul riposo e non restare mortificato”, aveva addolcito il tono il superiore, nel quale aveva avuto la meglio, finalmente, la compassione. Aveva proseguito: “Hai detto che il Perati faceva confessare tutti: certo, lo so bene, me l’avevano raccontato quand’ero arrivato qui; ma tu te lo ricordi chi l’aveva ammazzato?”
“Sissignore, la madre d’un ladro abituale…”
“…ladro cui il Perati aveva lanciato l’accusa d’aver accoltellato a una mano un panettiere, per derubarlo, e che aveva fatto confessare sì, ma come? Legandolo a pancia in su sopra un tavolo e frustandolo con la cinghia; e due giorni dopo, te lo ricordi? l’indagato era morto per un’emorragia interna.”
“Scusatemi, posso parlarvi liberamente ma con tutto il rispetto?”
“Puoi.”
“Io credevo che il dottor Perati fosse stato nel giusto perché non ne aveva avuto rimproveri da superiori.”
“Allora non sai che la faccenda era stata sepolta per ordine del federale di Napoli
, perché il Perati era fascistissimo e leccapiedi; e però, nella mente della madre del morto la cosa non era stata affatto seppellita, e oltretutto ella aveva appreso, un paio di settimane dopo la morte del figlio, ch’egli era innocente tanto del ferimento che del furto, e questo tu lo sapevi, no?”
“Sapevo che il vero colpevole era stato riconosciuto per strada dal panettiere e denunciato a una nostra pattuglia, dalla quale era stato fermato e portato qui.”
“Già, e la mamma del morto ne era stata messa al corrente da un amico del figlio, che aveva raccolto la verità in giro; e la sai una cosa? Non era stato troppo iniquo, in fin dei conti, che quella donna fosse venuta da noi chiedendo di parlare al Perati, con la scusa d’avere rivelazioni da fargli, e una volta davanti a lui avesse estratto un piccolo coltello per la spellatura della carne dal proprio seno e gli avesse mollato un fendente che gli era giunto al cuore; e quasi mi dispiace ch’ella fosse stata bloccata subito dopo e che adesso sia in attesa di giudizio, perché temo che sarà condannata a morte per omicidio premeditato.”
“Speriamo le concedano la seminfermità mentale”, gli era stato solidale il Bordin.
“Speriamolo; ma a parte questo, tu adesso mi vai al deposito automezzi con questo foglio di servizio… tieni: è la mia autorizzazione a prelevare una macchina con conducente; poi vai a controllare in vicolo Santa Lucia se l’Esposito è persona conosciuta.” Gli aveva sporto anche la patente dell’inquisito: “Fai vedere la foto alla madre, sempre se ella esiste, e pure ai vicini, e raccogli quanto puoi su di lui.”
“Agli ordini; al ritorno però, signor commissario, magari io me andrei in camera a dormire ché, per oggi, le mie ore di servizio sarebbero già scadute.”
“Dovere e sacrificio è il nostro motto”, gli aveva restituito sorridente, in uno spontaneo endecasillabo, il superiore, gran lettore di poeti classici.
Essendo noto in Questura che la temperatura sociale in città stava salendo e non era affatto improbabile una sollevazione, prima di recarsi all’autorimessa il brigadiere aveva voluto passare dalla sala radio per raccogliere notizie sulla situazione esterna. Non appena reso edotto, era tornato dal diretto superiore e l’aveva informato che camionette di ronda avevano comunicato ch’erano iniziati isolati scontri a fuoco. Aveva concluso chiedendo: “Signor dottore, devo proprio andarci oggi, o posso aspettare domani, ché forse il clima si sarà calmato?”
Prima che il D'Aiazzo avesse deciso, avevano preso a salire dalla via Medina, su cui s’affacciava e ancor s’affaccia la Questura di Napoli, i rombi dei motori diesel di automezzi che stavano passando in colonna davanti all’ingresso principale del palazzo, come tutti i giorni da due settimane: si trattava d’un plotone motorizzato di granatieri germanici che andava a dare il cambio a un altro, dello stesso battaglione, comandato a guardia d’un corridoio all’ultimo piano di Castel Sant’Elmo, possente baluardo che s’eleva sulla collina del Vomero a 250 metri sul livello del mare e da cui s’osservano il Golfo e la città: su quel corridoio s'affacciano due locali non comunicanti fra loro adibiti in quel tempo ad armeria del fortilizio, di cui uno è uno stanzone che conteneva armi e munizioni convenzionali e l'altro un ambiente non molto grande che custodiva armamenti segreti di progettazione e produzione italiane. La sorveglianza delle armi si svolgeva ventiquattr’ore su ventiquattro in due turni, dalle 8 e mezza alle 20 e 30 e dalle 20 e 30 alle 8 e mezza. Fin dal 9 settembre i tedeschi avevano occupato Castel Sant’Elmo impadronendosi degli armamenti, con particolare interesse per quelli speciali. Proprio a causa di tali armi non convenzionali, lo stesso castello era in quei giorni un obiettivo primario per gli Alleati che, da tempo, se ne stavano occupando coi propri servizi segreti.
Vittorio D’Aiazzo stava per rispondere al sottoposto di tralasciare il suo precedente ordine e d'andarsi a riposare, quando s’erano levati spari dalla via Medina, dapprima di fucili e d’un mitragliatore leggero, poi, in rapida successione, di mitra e d’una mitragliatrice.
Vice commissario e aiutante s’erano abbassati istintivamente e, avanzando a gambe semi piegate, s’erano portati alla finestra e avevano fatto capolino guardando di sotto, esponendosi il meno possibile.
Contemporaneamente, diversi altri poliziotti avevano sbirciato giù dai rispettivi uffici, tanto personale del turno smontante che di quello montante essendo l'ora del cambio, le 8 in punto; arrivato da poco, aveva spiato dalla propria finestra anche il caposezione vice questore Remigio Bollati; il suo ufficio dava sullo stesso corridoio su cui s’affacciava quello di Vittorio e i due locali erano contigui.
Occhieggiando di sotto s'era visto o intravisto, a seconda della posizione della propria finestra, a una cinquantina di metri oltre il portone e il limitrofo passo carraio, il plotone teutonico fermo in mezzo alla strada, al riparo dei propri automezzi allineati di traverso, impegnato in uno scontro a fuoco con persone che dovevano essere più in là sulla via e che non si potevano scorgere dal palazzo della Questura, ma di cui ben s’udivano gli spari: si poteva supporre che fossero riparate dietro i muri diroccati e i cumuli di macerie di due vicini palazzi, fra loro prospicienti, bombardati pochi giorni prima dell’8 settembre da fortezze volanti americane.
Capitolo 4
Per meglio intendere, torniamo un poco indietro:
Costituitosi il Fronte Unico Rivoluzionario partenopeo e vista la ritrosia del prefetto Soprano a prenderne la direzione, ne era stato eletto capo l’operaio settantenne Antonio Taraia che, il giorno 24 settembre, ritenendo la situazione ormai matura per l’insorgenza, aveva indetto per la mattina successiva una riunione nel liceo Sannazaro, onde metterne la decisione ai voti. La convinzione che fosse ormai tempo d’agire gli era venuta tanto dalla notizia che gli angloamericani erano ormai quasi alle porte di Napoli, giuntagli in anteprima dal filosofo Benedetto Croce che l’aveva saputa confidenzialmente dal dottor Soprano, quanto dal fatto che, in séguito ad accordi in codice intercorsi via radio cogli americani, erano state appena paracadutate di notte, presso Napoli, armi e radio ricetrasmittenti dell’US Army destinate ai partigiani, nascoste subito dopo in sette cantine in altrettante zone diverse della città; l’operazione s’era svolta col contributo essenziale d’un gruppo di prezzolati camorristi, pronti a correre gravi pericoli in vista dei guadagni molto alti promessi loro dagli americani: non ci si deve stupire di tale alleanza, gli Stati Uniti s’erano già avvalsi, e ancora si servivano, dell’aiuto della mafia nella Sicilia occupata dove, fra l’altro, numerosi nuovi sindaci notoriamente mafiosi erano stati insediati dai conquistatori; la camorra, così come la mafia, era organizzata quasi militarmente e, in particolare, poteva disporre in Napoli di molti grossi camion. L’operazione armi era stata organizzata dagli statunitensi con meticolosità; fra l’altro, foglietti d’istruzione sull’uso delle armi paracadutate, scritti in corretto italiano, erano stati portati al liceo Sannazaro da alcuni agenti americani che avevano oltrepassato di notte le linee, affinché i patrioti napoletani potessero essere istruiti teoricamente sul loro funzionamento dagli agenti stessi, il che avrebbe permesso di rendere più spedita e agevole l’istruzione pratica che, per ragioni logistiche, avrebbe potuto svolgersi solo poco prima della sollevazione, al momento del recupero delle armi nei sette depositi.
Nella riunione del 25 settembre la decisione d’insorgere era stata presa all’unanimità. Verso mezzogiorno erano stata inviati portaordini a darne notizia ai custodi del materiale bellico americano.
Il giorno seguente, domenica, sette patrioti capigruppo, che già avevano assistito allo stoccaggio delle armi nei luoghi segreti, s'erano presentati, uno per deposito, non molto prima dell’ora del coprifuoco, per predisporre il ritiro delle armi la stessa notte da parte dei propri uomini, i quali sarebbero giunti ai nascondigli verso le 5 antimeridiane del lunedì 27 settembre.
Dunque, dopo le 6 del mattino dello stesso 27 settembre, i gruppi di combattenti per la libertà, raccolte le armi s’erano diretti ai loro obiettivi. Mentre i plotoni istruiti nel liceo Sannazaro dagli agenti americani imbracciavano armi statunitensi, cioè fucili semiautomatici M1 Garand e mitragliatori BAR M1918 Browning che si avvalevano dei medesimi proiettili calibro 7,62, bombe a mano Mk2 ananas e lancia razzi portatili anticarro bazooka M1, gli altri gruppi d’insorti avevano armi catturate ai tedeschi negli scontri dei primi giorni, ossia fucili Mauser Kar 98 k, mitra MP80, bombe a mano 24 e granate Panzerwurfmine coi relativi lanciabombe anticarro Panzerfaust; inoltre coltelli personali o tratti dalle domestiche cucine e qualche doppietta già occultata dall'affezionato proprietario cacciatore, dopo l'occupazione tedesca, in cantina o soffitta.
Quella mattina tuttavia il primo fuoco non era stato preordinato, al contrario s’era acceso spontaneo al Vomero da parte di parenti di rastrellati, che avevano fermato un fuoristrada Kübelwagen Typ 82 della Wehrmacht uccidendo il maresciallo che lo guidava e mettendo in fuga gli altri militari; altre azioni non organizzate s’erano svolte poco dopo per Napoli e, qua e là, s’erano aggregati spontaneamente ai gruppetti ribelli coppie di carabinieri di ronda e agenti di pattuglia della Pubblica Sicurezza e della Guardia di Finanza; poco prima dell’inizio delle lezioni scolastiche, dieci studenti delle superiori disarmati erano volati d’impulso su tre tedeschi che procedevano di ronda in Kübelwagen a passo d’uomo, li avevano costretti a scendere, li avevano disarmati e avevano dato fuoco al loro fuoristrada, mentre il trio alemanno se la dava a gambe; tuttavia quei tedeschi avevano allarmato il loro reparto, per cui erano sopraggiunti due plotoni germanici col supporto di una potente autoblindo SdKfz 231 Schwere Panzerspähwagaen 6 rad; i dieci giovani s'erano rifugiati e barricati nel vicino Museo di San Martino e la blindo aveva iniziato a mitragliarne i finestroni, mentre voce dell’azione degli studenti e del pericolo ch’essi stavano correndo s'andava spandendo per Napoli, eco su eco.
Tra gli atti predisposti invece dalla Resistenza, c’erano stati anzitutto il noto attacco alla colonna dei granatieri tedeschi in via Medina e l’azione d’un plotone di carabinieri che, col beneplacito del colonnello comandante, s’era diretto, sopra un camion Lancia CM
, al Museo di San Martino per combattere, coi propri moschetti 91 corti e bombe a mano SRCM 35,
i tedeschi che assediavano gli studenti ribelli; al fianco dei militi della Benemerita s’erano posti spontaneamente alcuni civili della zona. Quella stessa mattina, sempre su precedente ordine dei dirigenti democratici, un centinaio di combattenti per la libertà aveva preso d’assedio Castel Sant’Elmo nel quale, fra i tedeschi asserragliati all’interno, c’era l’ormai stanco plotone di granatieri rimasto a guardia dell’armeria per tutta la notte, cui non era stato dato il cambio perché, come sappiamo, il fresco plotone montante era stato impegnato in combattimento in via Medina.
All’incalzare degli eventi il comandante della piazza colonnello Scholl aveva mosso i suoi potenti panzer di classe Tiger e Panther; tuttavia un certo numero ne era stato bloccato e incendiato da rivoltosi, grazie a qualche panzerfaust sottratto al nemico, a bazooka americani e a bottiglie molotov.
Capitolo 5
Mentre lo scontro a fuoco in via Medina continuava, il capo in testa della Questura, dottor Carmelo Pelluso, allontanatosi dalla finestra del proprio ufficio al primo piano, dalla quale aveva cautamente osservato il plotone tedesco impegnato in combattimento, s’era accinto a chiamare all’interfono i suoi vice questori per dar ordini in merito, quando il telefono sulla sua scrivania aveva trillato.
All’altro capo del filo c’era il suo diretto superiore dottor Soprano: Il prefetto aveva riferito al questore ch’erano iniziati conflitti a fuoco in più zone di Napoli e gli aveva riportato la notizia che la 5a armata e il 6° Corpo americani nonché il 10° britannico stavano attaccando i tedeschi in direzione di Napoli e di Avellino e i reparti germanici in campo stavano iniziando a ripiegare aggirando la città partenopea, per consolidare le loro linee più a nord. Aveva concluso lasciando arbitro il questore di decidere quali concreti ordini impartire ai propri uomini, ma col vincolo di non obbligarli a combattere i tedeschi.
Il dottor Pelluso non aveva obbedito del tutto: salutato il prefetto, aveva sì comandato ai suoi vice di trasmettere ai rispettivi dipendenti il semplice invito, non l'ordine, d'unirsi al popolo contro i tedeschi, ma aveva aggiunto deciso: “Dite a tutti che io personalmente sto con gl’insorti; tuttavia chiunque, per mera ipotesi, non volesse seguirmi non avrà noie; dovrà però consegnare la pistola e restare consegnato in Questura nelle camere di sicurezza.”
Carmelo Pelluso non era un antifascista della prima ora: come moltissimi altri, fra cui il vice commissario Vittorio D’Aiazzo, aveva posseduto sino al 25 luglio la tessera fascista, di fatto obbligatoria per i pubblici funzionari; aveva però aderito già alla fine di quel mese al Partito d’azione e non aveva mutato bandiera dopo l’occupazione tedesca e il recentissimo ritorno di Mussolini al Governo dell'Italia non occupata dagli eserciti alleati; al contrario, egli collaborava adesso attivamente coi dirigenti dei partiti antifascisti del Fronte Unico Rivoluzionario e, in primo luogo, con uno dei suoi maggiori esponenti, nonché suo amico personale, l’azionista
professor Adolfo Omodeo che, il 1° di settembre, era stato nominato dal Governo Badoglio rettore dell’Ateneo di Napoli Federico II, da cui alimentava fra gli intellettuali, insieme al liberale Benedetto Croce, la ribellione al nazifascismo.
I poliziotti fedeli a Mussolini, un commissario e una decina fra agenti, graduati e sottufficiali, sotto il diretto controllo del questore erano stati disarmati e rinchiusi, rispettosamente ma sotto scorta armata, nelle camere di sicurezza. Il Pelluso s’era informato se ci fossero già altri reclusi in quelle stanze e aveva saputo che l’unico in guardina era un certo, vero o presunto, Gennaro Esposito, sospettato dell’assassinio d’una prostituta di nome Rosa Demaggi. Sul volto del questore era apparso gran disappunto.
Negli stessi minuti, Vittorio D’Aiazzo stava uscendo di caserma attraverso il passo carraio, al comando d’una vecchia, obsoleta autoblindo della Questura. Egli si considerava in pectore un demoliberale cristiano anche se, gettata la tessera fascista il 25 luglio, non aveva aderito né al partito cattolico né a quello liberale e, a differenza del questore Pelluso, non aveva preso contatti con uomini della neonata Resistenza; d’altro canto, era stato così per la gran maggioranza di quegl’italiani che avrebbero poi combattuto il nazifascismo, per oltre un anno e mezzo, sino alla fine della guerra.
Con Vittorio D’Aiazzo era salito sull’autoblindo, anche se provato come lui per la notte insonne, il brigadiere Marino Bordin, uomo animoso benché rozzo il quale, pur non avendo idee politiche, nutriva profondo astio per i tedeschi a causa della loro boria sprezzante verso gl’italiani. Erano inoltre montati sul corazzato due agenti, tali Tertini e Pontiani, e alla guida s’era posto il maresciallo ordinario Aroldo Bennato, capo meccanico dell’autofficina della Questura, tutti e tre freschi, dopo una notte di riposo, e appena montati in servizio.
L’autoblindo, o precisamente autoblindomitragliatrice com'era catalogata, era un arnese della 1a guerra mondiale Ansaldo Lancia IZ dotato di tre mitragliere pesanti da 7,92 millimetri Maxim. Solo questo blindato e due consimili non erano stati confiscati alla Questura dagli occupanti, essendo stati giudicati non più utilizzabili perché obsoleti, a differenza delle più moderne autoblindo 611 FIAT 1934/35 e AB FIAT 1940/43 che i carristi teutonici avevano incamerato ben volentieri fra i loro mezzi corazzati. L’Ansaldo Lancia IZ era un modello lento e mal manovrabile. Aveva però una notevole potenza di fuoco, tanto che, entrato in servizio alla fine della 1a guerra mondiale, aveva fatto immediati sfracelli tra gli austriaci; inoltre, contrariamente a quanto dovevano aver pensato i tedeschi, le tre auto corazzate gemelle erano state tenute in perfetta efficienza grazie a revisioni periodiche del capo officina e dei suoi meccanici e, per le mitragliatrici, degli armieri.
Coi cinque poliziotti a bordo, il blindato era entrato fracassone e fumante nella via Medina, a una settantina di metri alle spalle dei tedeschi, sempre intenti a tirare sui rivoltosi per riceverne colpi di fucili Garand, mentre il mitragliatore BAR dei patrioti ormai taceva col suo addetto accasciato sopra bocconi, morto. Il numero degli attaccanti vivi s’era ridotto a meno della metà, ché i tedeschi disponevano d’una cosiddetta sega di Hitler, una tremenda mitragliatrice MG 42 da 7,92 millimetri, la migliore al mondo per efficacia e leggerezza, tanto che, ancor oggi negli anni 2000, il modello è in dotazione alla NATO
; e ogni dieci proiettili inseriti nei nastri dai mitraglieri teutonici, uno era di tipo perforante, capace di far breccia nei muri diroccati e nei cumuli di macerie delle due case bombardate, al cui riparo sparavano i patrioti. Anche alcuni tedeschi erano a terra morti, piccola parte del loro plotone.
Vittorio D’Aiazzo aveva ordinato al maresciallo di fermare il mezzo e agli agenti di mettersi a due mitragliatrici, mentre egli stesso si sistemava dietro alla terza. Il trio aveva armato, mirato ai granatieri nemici e, all’ordine del superiore, aveva fatto fuoco: senza sosta nonostante il rischio d’inceppare le armi. I tre mitraglieri improvvisati avevano eliminato il plotone avversario, i cui uomini non avevano fatto in tempo a voltare contro la blindo italiana l’MG coi suoi proiettili perforanti, che avrebbero potuto aver ragione della sottile copertura del mezzo italiano, e non erano riusciti, soprattutto, a lanciargli una bomba anticarro con un Panzerfaust che avevano in dotazione.
Dopo la strage di teutonici, l’autoblindo aveva ripreso la marcia, lentamente, e aveva oltrepassato, serpeggiando, i morti e gli automezzi nemici; per lo spazio insufficiente aveva scostato di forza una camionetta. A una quarantina di metri i patrioti superstiti, solo più sei persone di cui nessuna colpita, erano sbucati dalle macerie ed erano venuti allo scoperto andando incontro al blindato: erano cinque uomini e una donna esile e piccolina che dimostrava non più di diciott’anni e aveva sul volto un’espressione di spregio. Giunto il blindato a una decina di passi dal gruppetto, Vittorio aveva ordinato di sostare. Era sceso con tre dei suoi, lasciando a bordo il maresciallo presso la radio. I poliziotti e i partigiani s’erano occupati degl’italiani a terra, sedici, nessuno dei quali dava più segni di vita: sei di loro erano in condizioni agghiaccianti, quattro quasi segati in due da proiettili della MG, il quinto mancante del volto, sostituito da una cavità sanguinolenta, il sesto privato della calotta cranica onde si poteva vedergli il cervello mentre materia cerebrale gli era uscita dal naso e s’era rappresa su bocca e mento; la ragazza, avendo avuto quest’ultimo accanto durante il combattimento, aveva riferito al D’Aiazzo che il cerebro dell’uomo aveva pulsato per un po’ dopo aver subìto quei colpi devastanti; impassibile, ell'aveva così concluso il raccapricciante rapporto: “Non so se fosse ancora cosciente, perché era immobile, ma io credo proprio di sì.”
“Io spero proprio di no!” le aveva rimandato il vice commissario con malgarbo, infastidito non tanto dalla descrizione macabra, ma dalla freddezza che la giovane aveva mostrato.
Uno degli italiani uccisi aveva ad armacollo una piccola borsa in iuta con una radio statunitense Motorola Handie-Talkie SCR536 a una via, leggera ma non potente; la ragazza, sempre senza mostrare sentimenti, l’aveva tolta al defunto e se l’era messa a tracolla; aveva poi passato in rassegna, uno a uno con grande attenzione, i cadaveri dei tedeschi e, al termine dell’ispezione, il suo viso s’era incupito.
Vittorio aveva ordinato di togliere dal treppiede e prelevare la micidiale mitragliatrice MG coi suoi nastri di proiettili e aveva spiegato che, una volta smontata dal supporto, quell’arma poteva rendere assai bene come fucile mitragliatore, grazie al suo peso non eccessivo, appena una dozzina di chili, e a un suo bipiede sollevabile ripiegato sotto la canna. Era stata la ragazza, abbandonato il proprio fucile Garand, ad appropriarsene, dicendo che sapeva come usarla. S’era messa due nastri di proiettili della MG incrociati a bandoliera e aveva posato la mitragliatrice sulla propria spalla destra, tenendola bilanciata per la canna con la mano.
Il D’Aiazzo aveva afferrato il funesto Panzerfaust e aveva chiesto: “Qualcuno di voi sa usare quest’affare?”. Aveva avuto un sì da uno dei sei che, pur se in abiti civili, s’era dichiarato granatiere precisando ch'era stato “sorpreso qui a Napoli dall’armistizio.”
Un attimo dopo il maresciallo s’era sporto dallo sportello del blindato e aveva comunicato al superiore d’aver captato, dalla sala radio della Questura, la notizia che, via telefono, una voce femminile aveva chiamato il loro centralino denunciando che tedeschi stavano mitragliando le case di piazza Carità.
Vittorio aveva deciso d’intervenire. Dato che l’autoblindo poteva ospitare fino a sei persone, aveva offerto alla giovane d'entrarvi. Lei aveva rifiutato e, data l’urgenza, lui non aveva ripetuto l’invito, aveva dato l’ordine di salire ai propri uomini e, entrato per ultimo, aveva comandato al maresciallo di dirigere sull’obiettivo.
Molti altri poliziotti stavano uscendo intanto dalla Questura per affrontare tedeschi: c’era chi sortiva appiedato dal portone o da una porta secondaria, chi dal passo carraio sopra camion, camionette, motocarrozzette o a bordo delle due restanti autoblindomitragliatrici; i più imbracciavano ottocenteschi moschetti ‘91, qualcuno aveva ad armacollo un moderno mitra MAB
, molti portavano nei tascapane bombe SRCM o granate lacrimogene. Le destinazioni di tutti quei poliziotti erano le più diverse; in particolare, dietro preciso ordine del questore Pelluso, un plotone, di cui alcuni uomini vestivano abiti borghesi e la maggioranza la divisa, s’era diretto, sopra un autocarro lungo marca OM, verso piazzetta del Nilo, distante solo un chilometro da via Medina: su quel camion, nella cabina di guida accanto all’autista, c’era anche il presunto sergente maggiore Gennaro Esposito.
L’autoblindo al comando del D'Aiazzo era ripartita, sferragliando e scoppiettando, con dietro i sei patrioti a piedi. Il maresciallo Bennato la conduceva ad andatura lenta, non solo per la vetustà del veicolo, ma perché i partigiani appiedati che se ne facevano un po' baluardo potessero, senza stremarsi, seguirne l’andatura. Dopo il primo centinaio di metri uno dei sei, avendo considerato la complessione minuta della giovane donna, le aveva offerto di scambiare la pesante MG col proprio fucile, ma lei s’era rifiutata con fastidio emettendo, a bocca distorta, “Naah” il che, nelle intenzioni, doveva significare no.
Nell’avvicinarsi a piazza Carità, gli undici patrioti avevano cominciato a udire le ripercussioni di raffiche di mitragliatrice. Passati due minuti, erano giunti ai loro orecchi echi di mitra seguiti da una detonazione. Dopo un altro paio di minuti, erano risonate raffiche di mitragliatrici il cui crepitio era divenuto, via, via, più forte all’avvicinarsi della blindo, giunta adesso quasi alla piazza: era ormai fuor di dubbio che proprio là si stava sparando.
Vittorio aveva comandato al Bordin e ai due agenti di mettersi alle mitragliatrici e di armarle restando preparati a sparare al suo comando; da parte sua s’era messo dietro a una feritoia a prua per osservare fuori, pronto a ordinare il fuoco.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/guido-pagliarino/l-ira-dei-vilipesi/) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
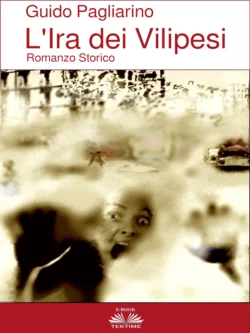
Guido Pagliarino
Тип: электронная книга
Жанр: Современная зарубежная литература
Язык: на итальянском языке
Издательство: TEKTIME S.R.L.S. UNIPERSONALE
Дата публикации: 16.04.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: 26 settembre 1943, Napoli è sul punto di ribellarsi ai tedeschi occupanti. Rosa, prostituta e borsanerista già confidente della polizia politica fascista, muore per cause violente. Gennaro, suo presunto assassino, è fermato e interrogato inutilmente da un ancor inesperto vice commissario, Vittorio. Poco dopo s′accende l’insurrezione che passerà alla storia come Le Quattro Giornate di Napoli. Vi aderiscono il vice commissario e, stranamente liberato dal questore in persona, il presunto assassino di Rosa. Partecipa alla lotta anche la giovane Mariapia che, dopo aver subito uno stupro plurimo da parte tedesca, brama vendetta. Presto Gennaro risulta essere suo parente. Avviene un altro assassinio, bersaglio un tabaccaio, anch′egli imparentato con Mariapia.